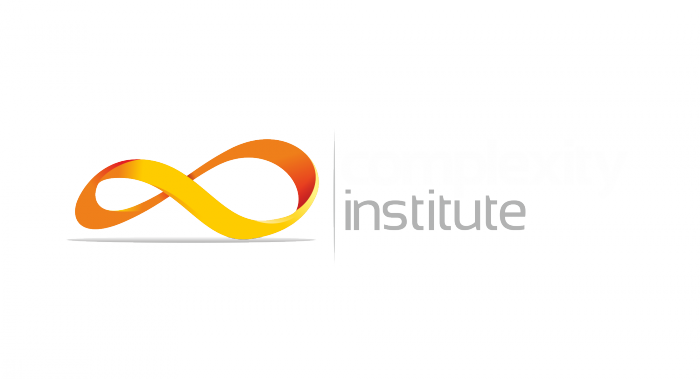Elogio dell'ambiguità
Un metodo per esplorare le possibilità di una situazione complessa
di Giuseppe Zollo
L’aggettivo ‘ambiguo’ viene dal verbo latino ambigĕre «dubitare, essere indeciso», composto da amb- «intorno» e da agĕre «spingere». Letteralmente, girare intorno alle cose. Una persona ambigua lascia perplessi sulle proprie intenzioni, è doppio, falso, di dubbia moralità, equivoco. Insomma, è un poco di buono. Identica è la definizione del sostantivo ‘ambiguità’. Il dizionario Treccani, dopo aver riportato la definizione neutrale di “possibilità di essere variamente interpretato”, vi associa i significati negativi di “doppiezza del comportamento” e “irresolutezza nell’azione”.
È impresa alquanto temeraria voler attribuire un ruolo positivo nell’ambiguità. Siamo inibiti dal fatto che l’ambiguità ha una connotazione negativa se associata alle persone, alle loro intenzioni, comportamenti e discorsi. Dopo tutto, nessuno vuole avere a che fare con soggetti equivoci e di bassa moralità, né sopporta di essere imbrogliato da giri di parole.
Quindi, mi corre l’obbligo di sollecitare il lettore a sospendere i riferimenti etici del termine ‘ambiguità’ e considerare solo il suo significato letterale: ‘qualcosa suscettibile di molte interpretazioni’, sinonimo di ‘polisemico’ (portatore di più significati) e di ‘plurivoco’ (che può assumere molti valori).
Per quanto possa sembrare sorprendente, l’umanità da circa 70.000 anni utilizza l’ambiguità come strumento per comprendere la complessità del mondo (1). Da quando nella storia umana si è compiuta la rivoluzione cognitiva che ha visto emergere il linguaggio, e con esso un universo simbolico fatto di segni, di immagini e di parole. Da allora la polisemia dei simboli ci ha sempre accompagnato coinvolgendo ogni nostra manifestazione: parole, gesti, immagini, oggetti, gesti, rituali, credenze e comportamenti.
Un esempio, i significati evocati dallo specchio nel medioevo:
purezza, quando è associato alla Vergine (speculum sine macula);
bellezza, quando è associato alla donna;
lussuria, associato ad una donna che si compiace del proprio corpo;
ammonimento della punizione divina, in quanto lo specchio riflette l’anima del peccatore;
orgoglio, quando è al servizio del demonio (2).
L’uso simbolico dello specchio persiste in molte culture. Rompere uno specchio è un presagio funesto. In molti paesi del Meridione con un morto in casa si coprono gli specchi. Il gesto evoca inconsapevolmente la credenza che lo specchio catturi l’anima del defunto e gli impedisca di andare via, verso il suo destino eterno.
Ma a cosa può mai servire un simbolo ricco di significati, per giunta contraddittori? Non è elemento di confusione che ci disorienta soltanto? Una risposta a questi interrogativi l’ho rintracciata in Pastoureau (3):
Il simbolo è sempre ambiguo, polivalente, proteiforme; impossibile racchiuderlo in qualunque formula. […] Nel mondo dei simboli suggerire è spesso più importante che dire, sentire più importante di comprendere, evocare più importante di dimostrare. […] Essi suggeriscono e strutturano il carattere dell’azione tanto quanto lo dicono. Fanno sentire e sognare più di quanto non indichino. Fanno entrare in quell’altra parte della realtà che è l’immaginario.
Dunque, il simbolo fa sentire e sognare, fa entrare in azione l’immaginario. Con la sua vaghezza semantica il simbolo mobilita il mondo interno dell’osservatore e lo spinge a tessere molteplici e impalpabili relazioni tra desideri, sogni, ricordi, e gli eventi del contesto. Insomma, l’ambiguità del simbolo ci dischiude le possibilità del mondo chiedendoci di dare voce alla nostra ricchezza interiore. La lettura simbolica dell’esperienza supera d’un balzo la perentoria assertività e univocità della analisi razionale dei fatti. Mediante il simbolo l’osservatore forza l’esperienza a svelare altri significati oltre a quello ovvio.
Ma cosa accade quando è la situazione a presentarsi ambigua? Gli esempi più efficaci vengono dall’arte. Considerate il dipinto di Vermeer La ragazza col turbante, meglio noto come La ragazza con l’orecchino di perla. L’ho mostrato in alcune conferenze e ho chiesto alla platea cosa stesse provando la ragazza. Le risposte sono state sempre molteplici: sorpresa, erotismo, soddisfazione, turbamento, innocenza, curiosità. Lo stesso accade osservando Les Meninas di Velasquez: cosa ha dipinto l’artista? L’infanta di Spagna con le sue damigelle, la coppia reale, sé stesso, o qualcosa di più astratto, come il significato della pittura? Ancora, cosa mai vorrà significare l’ambiguo sorriso de La Gioconda? Potremmo continuare a lungo l’elenco, perché il fascino segreto delle opere d’arte sta nel sollevare domande, molte domande, di invitarci a formulare molte ipotesi, molte possibilità. La nuova sensazione, la nuova ipotesi non cancella le precedenti: tutte continuano a persistere sovrapposte. Il fascino di questi dipinti deriva proprio dall’assenza di una interpretazione dominante: l’impossibilità di risolvere la situazione incatena lo sguardo dell’osservatore.
Mi sembra di poter concludere che nel campo dell’arte l’ambiguità svolge un ruolo positivo. Addirittura, ci procura piacere estetico. Ma nelle situazioni di ogni giorno? Ha una valenza positiva, o è qualcosa da evitare accuratamente?
Beh, qui la risposta è più complessa. Nelle situazioni quotidiane ne faremmo volentieri a meno. Vogliamo interagire con le cose, le persone e le situazioni avendo certezze. Come interagiamo con le icone del computer, che docilmente ubbidiscono alle nostre intenzioni. Quando faccio click sul rettangolino azzurro dell’articolo che sto scrivendo mi attendo che il computer faccia apparire l’immagine di un foglio su cui scrivere. Ovviamente, la realtà fisica del documento è un’altra: un insieme di stati di corrente di componenti elettronici, con cui interagisco mediante i fosfori dello schermo e gli impulsi della tastiera. L’icona del rettangolino azzurro assolve il compito di nascondermi la complessità della realtà fisica per permettermi di agire con velocità ed efficacia. Gli psicologi cognitivisti e gli scienziati evoluzionisti hanno generalizzato l’idea di icona, affermando che ciò sperimentiamo del mondo sono solo icone necessarie per la sopravvivenza (4). Per rendersene conto basta far riferimento ai colori. Gli animali vedono il mondo in modo diverso dal nostro, perché i loro recettori visivi sono sensibili a differenti lunghezze d’onda. I colori sono icone che specificano una realtà fisica. L’evoluzione ha selezionato per ogni essere vivente solo i recettori utili per la sopravvivenza. Icone diverse per ogni vivente. In fin dei conti, non ci interessa ciò che è vero, ma solo ciò che è utile.
Purtroppo per chi ama una vita tranquilla, il mondo è un po’ più complesso del computer. In rari casi le icone del mondo ci dicono esattamente cosa fare. In molti altri l’esperienza del mondo è troppo complessa perché una sola icona possa renderne conto. Ed è in questi casi che le situazioni diventano ambigue.
James March ha analizzato a lungo come persone e organizzazioni apprendono dall’esperienza, arrivando alla conclusione che l’esperienza è un ‘maestro imperfetto’ (5). Raramente l’esperienza ci dice esattamente cosa fare. Ciò per svariate ragioni:
le situazioni sono complesse: molte variabili sfuggono al nostro controllo e le relazioni tra causa ed effetto non sono chiare;
le situazioni sono piene di rumore ambientale: accadono tante cose, e non è facile distinguere quelle rilevanti da quelle che non lo sono;
le situazioni sono modificate continuamente dalla nostra azione e dalle azioni altrui: quindi, è difficile dare una interpretazione stabile;
le situazioni non si presentano mai uguali: piccole differenze possono produrre cambiamenti significativi.
In tali condizioni fidarsi delle proprie esperienze e andare dritti per la propria strada può essere un errore fatale. L’opzione migliore è mettere in discussione l’interpretazione dominante, vagliare altre possibilità, ampliare il ventaglio delle opzioni possibili, disporsi a passare da una all’altra man mano che i dati dell’esperienza si accumulano. In sostanza, nelle situazioni complesse è necessario fare quello che facciamo spontaneamente nella fruizione di un’opera d’arte: sviluppare e sovrapporre diverse interpretazioni e lasciare che esse convivano. La lezione che ne ricavo è che bisogna iniettare l’ambiguità nell’esperienza, utilizzare l’ambiguità come metodo per esplorare le possibilità di una situazione complessa.
Non so se sono stato in grado di convincervi che l’ambiguità ha una valenza positiva. A mio sostegno riporto una affermazione di E. Morin, il filosofo della complessità:
Gli spiriti umani sono stati educati ad eliminare l’ambiguità, ad accontentarsi di verità semplici, a praticare l’opposizione manichea del bene contro il male, e questo dappertutto, anche alle vette dell’Università. Come ha detto Toqueville: “Un’idea semplice, ma falsa, avrà sempre più peso di un’idea vera, ma complessa”. (6)
Note
1 Y.N. Harari, Da animali a dei. Breve storia dell’umanità. Bompiani, 2014.
2 F. Garnier, Le Langage de l’image au Moyen Age. Grammaire des gestes, Le Léopard d’or, 2003, pp. 223-226.
3 Le citazioni sono tratte da M. Pastoreau, Medioevo simbolico, Editori Laterza, 2004.
4 D.D. Hoffman, The Case Against the Reality. How evolution hid the truth from our eyes, Penguin Books, 2020.
5 J.G. March, The Ambiguities of Experience, Cornell University Press, 2010.
6 Edgar Morin, La sfida della complessità, Le Lettere, 2015, p. 74.
La foto di copertina è di Samuele Schirò da Pixabay
Per contattarci:
complex.institute@gmail.com
Cell. +39-327-3523432
Condividi:
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra)