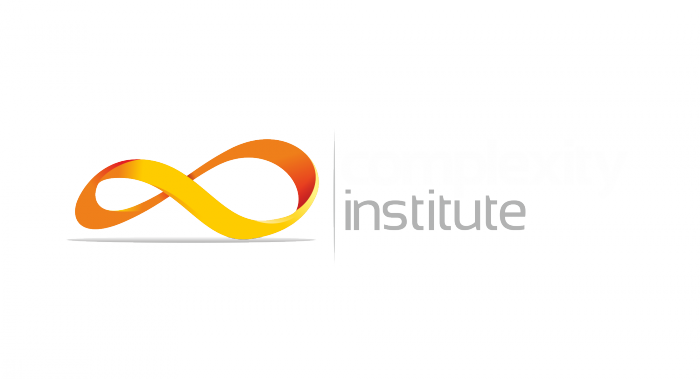Rivedere i presupposti dell'economia
Perché il benessere di ciascuno non è il benessere di tutti
di Marinella De Simone
Troppo e per troppo tempo abbiamo dato l’impressione di riporre l’eccellenza personale e i valori della comunità nella mera accumulazione di beni materiali. Il nostro Prodotto Interno Lordo, ora, ha superato gli 800 miliardi di dollari l’anno, ma il PIL – se intendiamo giudicare gli Stati Uniti d’America su quella base – comprende l’inquinamento dell’aria, la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per liberare le autostrade dalle carneficine. Mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte e le carceri per le persone che le forzano. Include la distruzione delle sequoie e la perdita, nell’espansione caotica, delle nostre meraviglie naturali. (…) Il PIL non calcola, invece, la salute dei nostri figli, né la qualità della loro istruzione o la gioia nel loro giocare. Non include la bellezza della nostra poesia né la forza dei nostri matrimoni, l’intelligenza del nostro dibattito pubblico e l’integrità dei nostri pubblici funzionari. (…) In breve, misura qualsiasi cosa, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. E ci può dire tutto sull’America, fuorché le ragioni per cui siamo orgogliosi di essere americani.
(Robert Kennedy, 1968)
Il benessere di un Paese non è il benessere delle persone che lo abitano
In un articolo precedente abbiamo affrontato il tema della dicotomia tra salute ed economia, sottolineando come la scelta di dover rinunciare alla salute per alimentare l’economia – rafforzata dall’epidemia da Coronavirus – sia necessaria per il modello economico attuale.
Misurare il benessere di un Paese in base alla crescita del PIL, ossia con una misurazione in termini monetari della produzione interna lorda, non consente affatto di definire il benessere delle persone che lo abitano. L’economia, così come si è affermata attraverso i secoli, ha favorito sempre più questa confusione tra incremento delle transazioni economiche e finanziarie (aspetto quantitativo) e aumento del benessere (aspetto qualitativo), lasciando intendere che dalle une sarebbe necessariamente disceso l’altro. La ricchezza di un Paese nulla ci dice sul come questa ricchezza sia stata prodotta e sui criteri con cui è stata distribuita. Entrambi questi aspetti giocano invece un ruolo essenziale sul nostro benessere.
Partendo dai criteri distributivi, stiamo assistendo – nonostante l’aumento quantitativo della ricchezza prodotta – ad una distribuzione sempre più iniqua della stessa, dove il “principio 80/20”, chiamato anche “legge di Pareto” – in cui l’economista italiano verso la fine dell’Ottocento aveva dimostrato che la ricchezza patrimoniale in Italia era per circa l’80% in mano al 20% della popolazione – trova sempre più riscontri anche nei Paesi considerati avanzati1. Smentendo così la tesi – largamente diffusa nell’approccio neoliberista – del “gocciolamento dall’alto verso il basso” della ricchezza: dai più benestanti ai ceti medi, e da questi ai ceti più poveri, benessere e ricchezza sarebbero state distribuite tra tutti i livelli sociali, purché si fossero lasciati sufficiente tempo e libertà di azione al mercato. Un recente rapporto di Oxfam2 dimostra come, nel 2018, in Italia il 20% più ricco possedeva circa il 72% dell’intera ricchezza nazionale, ed il 5% più ricco degli italiani era titolare da solo della stessa quota di ricchezza posseduta dal 90% più povero.
E queste tendenze sono in continuo peggioramento, amplificando il divario tra ricchi, ceto medio e poveri, con tutto ciò che ne consegue in termini di senso di ingiustizia e desiderio di rivalsa sociale, aprendo la strada a fenomeni come il populismo e l’aumento del conflitto sociale.
Il malessere prodotto da una sola impresa è il malessere di tutti
Il come viene generata la ricchezza è l’aspetto forse più deleterio e distorcente del concetto stesso di benessere. Il PIL misura in termini monetari ogni transazione economica e finanziaria di un Paese, indipendentemente dall’oggetto delle stesse. Dai pesticidi e fertilizzanti agli allevamenti intensivi per la produzione di carni e latticini, dai cibi-spazzatura alle bottigliette di plastica e ai TIR che le trasportano, tutto questo contribuisce alla ricchezza – e quindi al benessere di un Paese. Ogni evento, anche il più catastrofico – come un terremoto, o l’esondazione di un fiume, o un ponte che crolla sull’autostrada, o una nave-cisterna che si spezza in due nella barriera corallina riversando petrolio nel mare – può diventare un’occasione per trasformarsi in aumento del PIL.
Ciò che questo indice non misura sono le “esternalità negative” che tutto questo comporta: sofferenza, distruzione del paesaggio, perdita della storia e della cultura dei territori, perdita di biodiversità, distruzione ambientale, inquinamento, malattie, epidemie. Riducendo così lo stato di salute di un territorio e delle persone che lo abitano, con effetti spesso drammatici a livello non solo locale ma globale.
Le esternalità negative impattano su soggetti diversi rispetto a coloro che le hanno prodotte, e spesso colpiscono a più livelli il sistema sociale, fino a impattare su una intera collettività di persone e sull’ambiente, e difficilmente chi le produce si assume la responsabilità degli effetti delle azioni compiute e il conseguente onere economico per riparare a quanto generato.
E spesso, nei Paesi più avanzati come il nostro, è la parte pubblica – Stato, Regioni, Comuni – che viene chiamata in causa per porre rimedio a quanto prodotto dai singoli comportamenti degli operatori economici, con costi sociali ed economici elevati che ricadono su tutta la collettività.
Se si contabilizzassero le esternalità negative prodotte da questo sistema economico – come sarebbe opportuno fare – i dati risulterebbero estremamente diversi e più aderenti alla realtà sociale e ambientale. Basterebbe che i prezzi di vendita includessero i costi reali che l’azienda produce, non solo internamente ma anche esternamente, per avere un mercato molto più trasparente. Con il sistema attuale, invece, il malessere prodotto anche da una sola azienda diventa il malessere di tutti, senza che questo comporti alcun onere a suo carico.
Il benessere di tutti è il benessere di ciascuno
Occorre quindi non rinunciare alla ricchezza, ma operare sui modi con cui essa viene prodotta e sui criteri con cui viene distribuita, intervenendo sulle cause che generano queste distorsioni, anziché dover correre ai ripari per correggerne gli effetti.
Se individualmente dobbiamo rinunciare alla salute per poter mantenere in funzione l’economia, se collettivamente deve essere lo Stato a farsi carico delle esternalità negative prodotte dall’economia, sono i presupposti su cui è fondata l’economia che devono essere rivisti.
Viviamo in una sorta di “naturalismo economico” – di cui parla Massimo Mercati nel suo libro3 – in cui siamo convinti che ciò che esiste oggi a livello economico, dalle regole di funzionamento del mercato alle istituzioni che vi operano come le imprese – sia immutabile, una sorta di stato di fatto che non può essere cambiato e a cui dobbiamo conformarci. Lo Stato può solo intervenire per mitigare gli effetti delle leggi economiche che ne regolano il funzionamento.
Abbiamo così una seconda dicotomia, che riguarda prettamente l’ambito economico e che perdura da più di due secoli: quella tra Stato e mercato. La discussione se dare ancor più potere al mercato – lasciandolo libero di competere ferocemente fino a organizzarsi in oligarchie economiche e finanziarie – o dare più potere allo Stato – intervenendo in modo direttivo attraverso leggi e divieti – prosegue ancora oggi, senza riuscire, tuttavia, a trovare una soluzione efficace.
È possibile Invece contemplare una terza via, che superi la dicotomia tra mercato e Stato: cambiare il modo in cui intendiamo l’agire delle nostre istituzioni economiche e lo scopo per cui esse esistono ed operano, allargando la visione all’intero sistema nel quale sono inserite e di cui sono parte.
Occorre ridisegnare le regole su cui sono fondate le imprese, considerandole per ciò che devono essere: delle istituzioni con una funzione economica e sociale. Non per trasformare tutti in consumatori compulsivi, ma per produrre beneficio economico e sociale verso il proprio territorio e la propria comunità. Non per estrarre ricchezza – dall’ambiente e dalla salute delle persone – che non potrà mai più essere ricreata e sarà perduta per sempre, ma per riprodurre ricchezza, rigenerandola attraverso esternalità positive, che accrescono il benessere delle persone e del territorio. Non con una mera contabilità di scambio – dare e avere, profitti e perdite – ma con misurazioni che tengano conto anche dell’impatto dell’impresa nel generare esternalità negative e positive e di come abbia assolto la propria funzione economica e sociale.
Fare profitto è necessario per mantenere in essere l’impresa, ma non deve rappresentare lo scopo ultimo della sua attività, a cui tutto il resto deve piegarsi. Dal raggiungimento dell’interesse privato abbiamo imparato, a nostre spese, che non deriva il raggiungimento dell’interesse collettivo, né che dal benessere di ciascuno deriva il benessere di tutti.
Le imprese operano ancora, e sempre più – salvo rare eccezioni, come le imprese che esplicitamente perseguono come scopo il beneficio comune, come le società benefit – con un’ottica non inclusiva ma esclusiva, in cui il beneficio prodotto è solo ciò che è misurabile in termini monetari come profitto, da riservarsi solo ai soci.
Considerare le imprese come istituzioni con una funzione economica e sociale comporta necessariamente includere nella valutazione del loro operato la collettività, la comunità di appartenenza, il beneficio comune che esse sono in grado di dare. L’attivazione della funzione economica e sociale può avvenire introducendo il principio di reciprocità nelle relazioni dell’impresa, sia all’interno con i propri collaboratori e dipendenti, sia all’esterno con i propri clienti e fornitori e con la comunità tutta. È su questi elementi che l’impresa dovrebbe essere valutata sotto l’aspetto economico, finanziario e patrimoniale dai soci, dai clienti, dalla filiera produttiva, dai finanziatori, dallo Stato. È su questi elementi che dovrebbe essere finanziata e tassata.
Il comportamento reciprocante4 si manifesta quando “si dà senza perdere e si riceve senza togliere”, e supera il mero scambio di equivalenti su cui è fondato il nostro modello economico attuale, in cui si dà perdendo e si riceve togliendo. Per poterlo applicare, occorre che vi sia fiducia e cooperazione tra le parti coinvolte in vista di un obiettivo comune: il benessere delle parti e il benessere dell’intera collettività. Perché, se il benessere di ciascuno non è il benessere di tutti, il benessere di tutti diviene benessere di ciascuno.
Note
1 OECD, Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD Publishing, 2011.
2 Oxfam, Bene pubblico o ricchezza privata?, Oxfam Briefing Paper, gennaio 2019.
3 Massimo Mercati, L’impresa come sistema vivente, Aboca, 2020.
4 Stefano Zamagni, Prudenza, Il Mulino, 2015.
Per contattarci:
complex.institute@gmail.com
Cell. +39-327-3523432
Condividi:
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra)